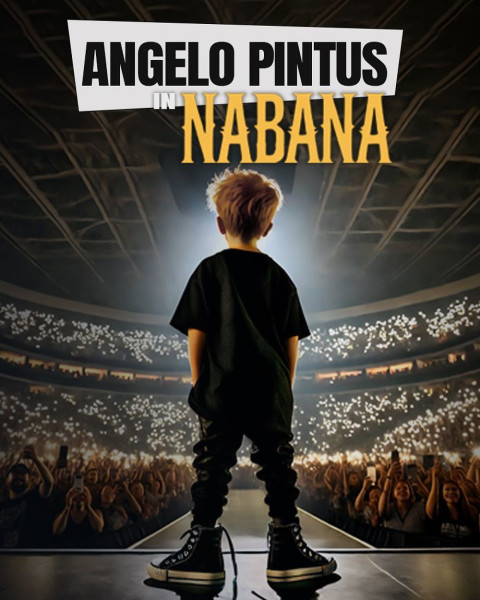Cara Annabella 🥀,
Avrei voluto poterti conoscere.
Avrei voluto poterti parlare.
Avrei voluto poterti dire: “So cosa senti, e so che c’è una via d’uscita. Anche se quello che senti ora lo capirai solo fra molti anni…”
Ma non ho potuto. Nessuno ha potuto.
E forse è proprio questo il punto: non sempre ci accorgiamo di chi sta urlando in silenzio.
Non sempre sappiamo leggere gli sguardi che chiedono aiuto senza parole.
Non sempre abbiamo il coraggio di fermarci davanti a qualcuno che dice “sto bene” quando sappiamo che non è vero.
Hai percorso 25 chilometri in bicicletta, di notte, verso i Colli Euganei.
Hai comprato due pizze, come se dovessi incontrare qualcuno.
Forse speravi, fino all’ultimo, che qualcuno arrivasse davvero. Che qualcuno ti fermasse. Che qualcuno capisse.
Giulia ti ha incontrata quella sera. Ti ha offerto aiuto. Tre volte.
E tu hai detto no, con calma. Senza agitazione.
Perché quando hai già deciso, quando il dolore è diventato più forte della paura, diventi stranamente tranquilla.
Lo so. Ci sono passato anch’io, in quel punto esatto dove il mondo sembra stringersi in un tunnel senza luce.
Ma ecco la cosa che avrei voluto dirti: quel tunnel finisce.
Davvero.
Non è retorica. È matematica emotiva.
Quello che ti sembra definitivo a 22 anni, tra cinque anni sarà solo un capitolo. Doloroso, sì. Ma un capitolo. Non il libro intero.
La fine di una storia d’amore a 22 anni è un terremoto.
Gli esami che non dai sono un fallimento che brucia.
La solitudine è cemento che ti cola addosso finché non riesci più a muoverti.
Lo so. Ma tutto questo cambia.
Tu saresti cambiata.
Il dolore si trasforma. Non scompare, ma smette di soffocarti.
Avrei voluto dirti che la pace che cercavi — quella che “non riconoscevi più”, come hai scritto — non l’avevi persa per sempre. Era solo nascosta.
Sotto strati di tristezza, delusione, stanchezza. Ma era lì. E sarebbe tornata.
Ma soprattutto, Annabella, avrei voluto dirti questo: IL DOLORE MENTE.
Ti dice che sei sola, e non è vero.
Ti dice che nessuno capisce, e non è vero.
Ti dice che non cambierà mai, e non è vero.
Il dolore è il bugiardo più convincente del mondo. E tu gli hai creduto.
Non ti giudico. Non potrei mai.
Perché so quanto è difficile resistere quando quella voce dentro diventa assordante.
So cosa significa sentirsi trasparenti, come se nessuno ti vedesse davvero.
Ma sei stata vista.
I tuoi genitori ti stavano cercando. Gli amici ti cercavano. Giulia ti ha offerto aiuto.
Il problema non era che nessuno si accorgeva di te. Il problema forse era che tu non riuscivi più a sentirti degna di essere aiutata.
Forse una lettera non ti avrebbe salvata.
Ma forse non è troppo tardi per qualcun altro che sta leggendo.
Qualcuno che si sente come ti sentivi tu.
Qualcuno che sta pensando che la bicicletta, la notte, il bosco… siano l’unica soluzione.
A quella persona voglio dire: ASPETTA. 🛑
Aspetta un giorno in più. Poi un altro. Poi un altro ancora.
Non perché ti prometto che domani starai meglio — forse no.
Ma perché tra un anno, tra cinque, tra dieci, guarderai indietro e non riconoscerai più quella persona disperata.
E sarai grato di aver aspettato.
Annabella, il tuo dolore non è stato inutile.
La tua storia ha scosso tutti noi.
Ha aperto conversazioni.
Ha fatto chiedere a genitori, amici, insegnanti: “Sto davvero ascoltando? Sto davvero vedendo?”
Riposa, Annabella.
Quella pace che cercavi, adesso ce l’hai.
E noi, quelli rimasti, abbiamo il dovere di fare in modo che nessun altro debba cercarla in quel modo.
Ti avrei voluta conoscere.
Ricky
🔴 SE STAI MALE, CHIEDI AIUTO ORA:
📞 Telefono Amico Italia: 02 2327 2327
(Attivo H24, gratuito, anonimo. Ti ascoltano davvero.)
📞 Numero Verde Anti-Suicidio: 800 334 343
Non sei solo. Anche se il dolore ti dice il contrario.lettera Annabella Martinelli solitudine